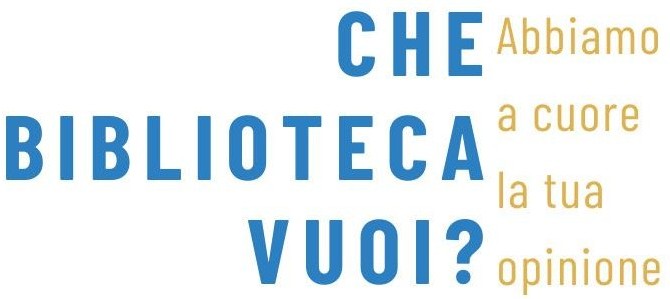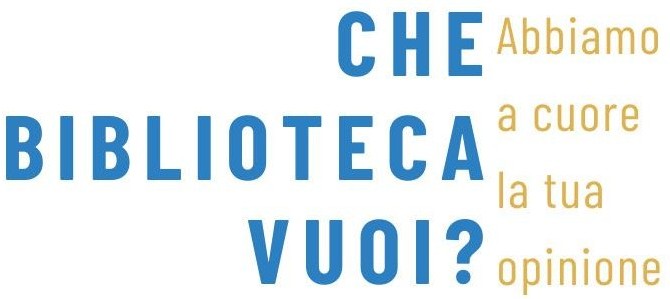Monografia a stampa
Monografia a stampa
Della Volpe, Galvano
Milano : Feltrinelli, 1976
Abstract/Sommario: Galvano della Volpe (1895-1968) con Critica del gusto formula una teoria organica della letteratura nell’ambito dell’estetica materialistica e marxista. Egli afferma il valore razionale, e non sentimentale, dell’opera artistica (a riguardo si veda il capitolo primo, «Critica dell’ ”immaginazione” poetica»). Il carattere razionale dell’arte, sostiene Della Volpe, è unità, coerenza, armonia. Per Della Volpe la forma è concetto, mentre il contenuto è materia molteplice del sensibile, dell ...; [Leggi tutto...]
Galvano della Volpe (1895-1968) con Critica del gusto formula una teoria organica della letteratura nell’ambito dell’estetica materialistica e marxista. Egli afferma il valore razionale, e non sentimentale, dell’opera artistica (a riguardo si veda il capitolo primo, «Critica dell’ ”immaginazione” poetica»). Il carattere razionale dell’arte, sostiene Della Volpe, è unità, coerenza, armonia. Per Della Volpe la forma è concetto, mentre il contenuto è materia molteplice del sensibile, dell’immaginazione.
«l’istanza della “coerenza” quale fattore fondamentalissimo dell’opera poetica come tale [ …] resta inspiegabile se si intenda la coerenza come coerenza “fantastica”, cioè istituita dalla fantasia o immaginazione invece che nella fantasia; non dandosi coerenza ossia unità (e quindi universalità) se non per la e nella ragione: se non col rationale… » (pag.6)*
Quindi l’arte non si distingue dalla conoscenza scientifica giacché entrambe si caratterizzano in unità del concetto. La differenza tra scienza e arte, invece, si rivela nella loro natura semantico-espressiva. Il linguaggio scientifico è univoco, aperto, onnicontestuale e universale; mentre il linguaggio poetico è polisenso, autonomo, plurale, chiuso. Dello specifico carattere semantico della poesia, dunque, Galvano della Volpe verifica e conferma l’autonomia della creazione poetica. Sicché, prendendo le mosse dalla Poetica di Aristotele, Della Volpe utilizza la gnoseologia della linguistica saussuriana e l’aspetto tecnico dell’ opera d’arte per attaccare la concezione romantica della poesia come ineffabilità, difetto che il Nostro rintraccia anche in buona parte della critica di ispirazione marxista (per esempio in Lukács, considerato ancora legato alla concezione romantico-intuizionistica).
A conclusione di questa breve nota, a me pare che, nonostante i tanti anni che ci dividono dalla prima edizione, Critica del gusto continui a sollevare dubbi e solleciti gli studiosi a riflettere su alcuni problemi non risolti di teoria letteraria ed estetica. (Francesco Sasso).