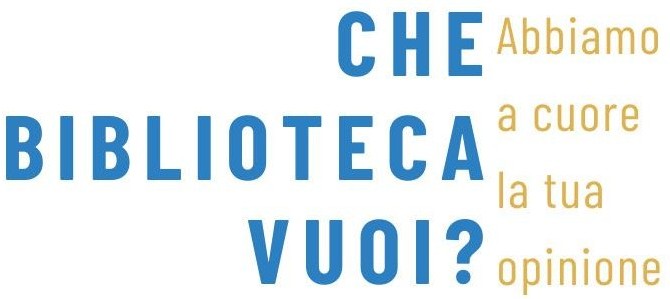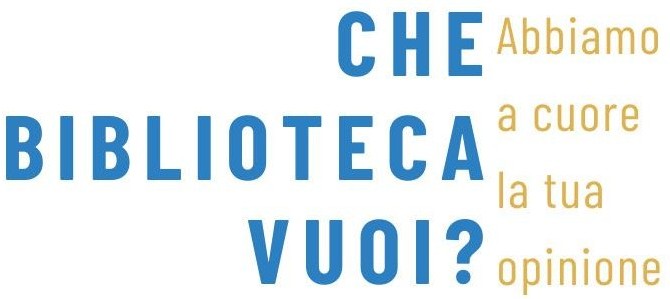Monografia a stampa
Monografia a stampa
1 : Il Cinquecento : l'età del Rinascimento. Storia
Roma : Gruppo editoriale L'Espresso, 2012
Abstract/Sommario:
l Cinquecento è un secolo difficile da definire, specie in Italia, perché evoca delle periodizzazioni storiche molto convenzionali e ingannevoli. C’è una certa tendenza a identificare il Quattrocento con l’Umanesimo e il Cinquecento con il Rinascimento. Eppure quel movimento di riscoperta delle humanae litterae e dell’eredità classica che caratterizza l’Umanesimo inizia ben prima, almeno con il Petrarca, che vive nel XIV secolo (quello che secondo l’uso italiano è chiamato il Trecento) ...; [leggi tutto]
l Cinquecento è un secolo difficile da definire, specie in Italia, perché evoca delle periodizzazioni storiche molto convenzionali e ingannevoli. C’è una certa tendenza a identificare il Quattrocento con l’Umanesimo e il Cinquecento con il Rinascimento. Eppure quel movimento di riscoperta delle humanae litterae e dell’eredità classica che caratterizza l’Umanesimo inizia ben prima, almeno con il Petrarca, che vive nel XIV secolo (quello che secondo l’uso italiano è chiamato il Trecento), e d’altra parte gran parte di quei fenomeni che noi riconosciamo come tipicamente “rinascimentali” si manifestano proprio nel Quattrocento. Tanto è vero che, almeno per quanto riguarda la storia dell’arte, molti storici considerano il periodo rinascimentale concluso nel 1520, anno della morte di Raffaello (dopo inizia quello che si suole chiamare manierismo). Eppure c’è una data che segna l’inizio di un mutamento epocale, ed è il 1492. Una data-cerniera, e per due ragioni. La prima, la più facilmente riconoscibile, è che in quell’anno Cristoforo Colombo sbarca sul continente americano. Si può discutere se sia il primo a raggiungerlo e se sia ancora “politicamente corretto” parlare di “scoperta dell’America”, come se gli abitanti autoctoni di quel continente attendessero il navigatore genovese per riconoscere la propria identità; ma certamente per l’Europa quella data segna la nascita di una diversa visione del globo, un subitaneo allargamento di confini non solo geografici, e da questo ampliamento di spazi fisici e mentali consegue un diverso assestamento dei rapporti politici ed economici nell’intero continente, e delle prospettive culturali. La seconda ragione per cui quest’anno è significativo è che esso segna il compimento della Reconquista, ovvero della definitiva cacciata dei Mori dalla Spagna. L’Europa si disegna ora come continente totalmente cristiano, la Spagna (fortificata anche dal successo della navigazione di Colombo) si presenta definitivamente come grande potenza, “spagnolizza” per prima il nuovo continente e dà l’intollerante avvio alla seconda diaspora, disperdendo la cultura ebraica sia nell’area mediterranea che nella mitteleuropa. Se poi sembrasse azzardato fare iniziare il Cinquecento con otto anni d’anticipo, lo si potrebbe fare incominciare con alcuni anni di ritardo. Altra data epocale è il 1517, inizio ufficiale della Riforma protestante, fenomeno religioso, culturale e politico a un tempo, che concorre anch’esso a riassestare gli equilibri europei. Tre eventi del genere non possono non stabilire un’ideale linea di confine tra due epoche, anche se al di sotto, o al di sopra, di questa “frattura” scorre una continuità di temi, di atteggiamenti, di discorsi che provengono dal secolo precedente. Nell’arte, tiene a battesimo il nuovo secolo la Gioconda leonardesca, maturano definitivamente Raffaello e Michelangelo, trionfano Dürer, Holbein il Giovane, Tiziano. L’uomo moderno parla con la voce di Montaigne, Thomas More, Campanella, Erasmo. A metà secolo la visione dei cieli si ribalta attraverso la rivoluzione copernicana, Ariosto pone un’ironica pietra tombale sugli ideali cavallereschi del passato e mentre lamenta l’apparizione dell’archibugio, riconosce l’avvento di una nuova tecnica militare. Al di là delle Alpi la risata di Rabelais seppellisce la cultura tradizionale, al di qua Machiavelli ci sottrae ogni illusione e ci parla di un nuovo modo, spietatamente realistico, d’intendere l’arte della politica. Paracelso e Vesalio trasformano l’arte medica; si affermano nuove immagini e della città e della corte; mentre si formano le Chiese protestanti, la Chiesa cattolica si ristruttura attraverso la Controriforma tridentina. Ce n’è abbastanza per parlare di un secolo in cui, tra fermenti di rinnovamento, insofferenze per antiche scienze sacre o profane, si forma una nuova immagine dell’uomo e della natura e si assesta definitivamente l’era moderna. Se ha un significato la proposta di considerarci, noi contemporanei, definitivamente postmoderni, è comunque con la modernità cinquecentesca che dobbiamo confrontarci, sia per sapere chi siamo (e perché) sia per capire in che senso ci riteniamo diversi.
[comprimi]